|
CAPITOLO XXIII MARAVIGLIOSE COSE VEDUTE DAL CELEBRATISSIMO DON CHISCIOTTE NELLA PROFONDA GROTTA DI MONTESINO E DA LUI RACCONTATE, LA CUI GRANDEZZA E IMPOSSIBILITĄ VA A STABILIRE PER APOCRIFA LA PRESENTE VENTURA.
Il sole verso le quattro della sera velato da nubi, con iscarsa luce e con temperati raggi diè agio a don Chisciotte che senza caldo e molestia potesse accingersi a raccontare ai due suoi illustri uditori ciò che veduto aveva nella Grotta di Montésino; e cominciò nella seguente maniera: «Dodici a quattordici stadi all'incirca, sotto la profondità di questa spelonca, evvi a mano diritta una cavità ed uno spazio atto a contener un gran carro colle sue mule, dove entra piccola luce da certe fessure e pertugi che da lungi vi corrispondono, e che hanno origine dalla superficie della terra. Questa cavità o spazio vid'io quando trovandomi stanco e disgustato dello stare pendente ed attaccato a quella fune camminai per quella oscura regione senza avere direzione alcuna sicura e determinata; e mi persuasi allora di fermarmi e di riposare un poco. Gridai e dissi che non si calasse più fune senz'altro mio avviso; ma credo che voi non mi abbiate udito. Attesi allora a raccorre la fune che stavate calando, facendo di essa una ciambella, e mi vi sedetti sopra pensoso e in dubbio del come appigliarmi per calare sino al fondo, non avendo chi mi sostenesse. D'improvviso e a mio malgrado fui colto da profondissimo sonno, e senza che io ne sappia né l'istante né il come, mi risvegliai trovandomi nel mezzo del più bello, ameno e dilettevole prato che mai formasse natura ovvero creasse la più fervida umana immaginazione. Apersi, ravvivai, stropicciai gli occhi, e mi accorsi che io non dormiva altrimenti; ma ch'ero svegliatissimo: con tutto ciò volli tastarmi e il petto e la testa per accertarmi ch'io era veramente io, e non qualche vana e contraffatta fantasima. Il tatto, il sentimento, il concorde discorso che facea tra me e me tutto m'assicurò ch'ero in effetto io medesimo, e quel medesimo che ora qui vedete. Allora mi si offerse alla vista sontuoso e reale palagio, o castello, le cui pareti sembravano fabbricate di trasparente e lucido cristallo: apertesi due grandi porte dello stesso, vidi che uscia, ed avviavasi alla mia volta un venerabile vecchio, vestito con cappuccio di rovescio pavonazzo che strascinava a terra, con manto da collegiale togato, e tutto di raso verde che gli cingeva gli omeri e il petto, colla testa coperta da berettino alla milanese nero, e con barba bianchissima che gli arrivava fin sotto alla cintura. Nessun'arme portava, ma teneva un rosario in mano coll'avemmarie più grosse che noci ordinarie, e le poste del rosario erano come mezzane ova di struzzo. Il contegno, il passo, la gravità, la maestosissima presenza sua ed ogni altra cosa che in lui ebbi campo di considerare mi tennero maravigliato e fuori di me. Mi si avvicinò, ed il primo suo movimento fu di strettamente abbracciarmi, e poi dirmi: — Č molto tempo, o valoroso cavaliere don Chisciotte della Mancia, che noi, i quali tra queste solitudini stiamo incantati, attendiamo di vederti, affinché avesse notizia il mondo per mezzo tuo di ciò che rinserra e copre la profonda grotta per dove entrasti, chiamata la grotta di Montésino; grotta visitata per la prima volta dal tuo invincibile cuore e dal maraviglioso tuo braccio. Seguimi adesso, signore preclarissimo, che voglio mostrarti le stupende cose che si celano in questo trasparente castello, di cui io sono il custode e la perpetua guardia maggiore, essendo io quel Montésino medesimo da cui prende il nome questo luogo.» Appena mi ebbe detto ch'egli era Montésino stesso, ch'io gli chiesi se fosse verità ciò che nel mondo di qua raccontavasi, cioè di aver egli cavato dal mezzo del petto con picciola daga il cuore del suo amico Durandarte, e poi inviatolo alla signora Belerma, come quegli comandò e volle al punto del suo morire. Risposemi che tutto era verità, ad eccezione della daga, la quale non fu daga veramente né picciola né grande, ma sì bene pugnale scannellato, più acuto di una lesina. — Sarà stato, soggiunse allora Sancio, un pugnale di Ramon di Ozes il sivigliano. — Non lo so, continuò a dire don Chisciotte; ma non può essere di questo venditore di pugnali, perché quello di Ramon di Ozes è moderno, e l'altro di Roncisvalle, ove accadde questo infortunio, conta infinito numero di anni: ma già la verità e il testo di questa istoria non può essere gran fatto alterato dalla verificazione di cotal circostanza. — Così è per lo appunto, soggiunse il giovane; e prosegua la signoria vostra, signor don Chisciotte, che io sto ad ascoltarla con grandissima soddisfazione. — Né con minore io farò il mio racconto rispose don Chisciotte; e perciò dico che il venerabile Montésino m'introdusse nel cristallino palazzo, dove in una sala terrena, freschissima soprammodo e tutta di alabastro giaceva un marmoreo sepolcro con somma maestria fabbricato; sopra il quale vidi un cavaliero disteso quanto era lungo, e non già di bronzo o di marmo, né formato di diaspro alla foggia di quelli che scorgonsi nei sepolcri di costassù, ma di vera carne e di vere ossa. Teneva la destra mano, che mi parve un po' pelosa (segno di sua gran forza) posta sul lato del cuore, e prima che io facessi a Montésino richiesta alcuna, vedendomi egli attonito a guardar quello del sepolcro, mi disse: — Questo è l'amico mio Durandarte, fiore e specchio dei cavalieri innamorati e valorosi del tempo suo; il quale (come lo sono io e molti altri) resta qua incantato per opera di Merlino, di quel francese maliardo che dicono essere stato il figliuolo del demonio, ma che per mio avviso non fu già figliuolo del demonio, ma più del demonio saputo di un punto, come suol dirsi. Ognuno ignora la ragione del nostro incantesimo, ma si saprà bene col volger degli anni, che non dovrebbero essere ancora molti per quanto vo immaginando. Quello poi di cui stupirete si è, ch'io sono così certo come adesso che voi siete qui, che Durandarte pose fine ai suoi giorni fra le mie braccia, e che dopo la sua morte io gli cavai colle proprie mani il cuore; il quale, senza esagerare, pesar doveva due libbre: e voi avrete già inteso dai naturalisti che chi ha il cuore di mole grande è dotato di maggiore bravura di chi lo ha piccino. — Passando la cosa dunque in tal modo, ed essendo vero che realmente morì questo cavaliere, come fa egli, io replicai, a dolersi ed a sospirare di tanto in tanto come se fosse ancor vivo? Proferite appena tali parole il misero Durandarte sclamò: «O mio cugino Montésino, l'ultima mia preghiera fu che dopo la mia morte tu portassi il mio cuore a Belerma traendolo dal mio petto con un pugnale o con una daga.» Udito, questo, il venerabile Montésino si mise tosto ginocchioni dinanzi al dolente cavaliere, e così proruppe, spartendo un mare di lagrime:
— E quando ciò non segua, rispose l'incantanto Durandarte con bassa e fioca voce, quando altrimenti succeda, o cugino mio, bisognerà aver sofferenza e batter le carte.
— Adagio un poco, allora diss'io, signor don Montésino: proceda vossignoria nel racconto della sua istoria com'è di dovere, ché odioso è sempre qualunque paragone, e non si dee mettere a confronto questa con quella. La senza pari Dulcinea del Toboso è quello che è, e la signora Belerma è chi è e chi è stata; e basti così. Al che mi rispos'egli: Signor don Chisciotte, perdonimi, vossignoria, ché confesso di essere caduto in errore, e ho detto male nell'asserire che la signora Dulcinea sarebbesi appena pareggiata alla signora Belerma, perché avendo scoperto in voi il suo cavaliere avrei dovuto mordermi la lingua prima di porla a confronto con altri che col cielo. La soddisfazione ch'io ebbi dal gran Montésino mise tranquillità nel mio cuore ch'era molto turbato per quell'odiato confronto della mia signora colla signora Belerma.» — E ancor io mi meraviglio, disse allora Sancio, che vossignoria non siasi scagliato contro il vecchiaccio, e non gli abbia fracassate le ossa e strappati tutti i peli della barba senza lasciargliene pur uno. — No, amico Sancio, rispose don Chisciotte, non mi conveniva far questo, correndo obbligo a tutti di rispettare i vecchi quantunque non sieno cavalieri, e quelli segnatamente che sono incantati: e posso assicurarti che nulla vi fu di che dire nei successivi ragionamenti occorsi fra noi.» Disse a questo passo il giovane: — Non so capire, signor don Chisciotte, come vossignoria nel breve spazio di tempo che stette laggiù, abbia tante cose vedute, né come possono essere corse tante proposte e risposte. — Quanto è che io vi calai? domandò don Chisciotte. — Poco più di un'ora, rispose Sancio. — Ciò non può essere, replicò don Chisciotte, perché in quel soggiorno mi colse la notte, tornò la mattina, fece notte un'altra volta, e tre altre volte mattina, di guisa che, secondo il mio conto, per tre giorni sono rimasto in quelle remote parti, e me ne stetti nascosto alla vista del mondo. — Il mio padrone deve dire la verità, soggiunse Sancio; ché siccome le cose accadute sono tutte per incantesimo, chi sa che quello che a noi pare un'ora, non debba parere agli altri tre giorni colle loro notti. — Sarà così, rispose don Chisciotte. — E vossignoria, signor mio, soggiunse il giovane, non ha mangiato mai in questo corso di tempo? — Non ho rotto il digiuno nemmeno con un solo boccone, rispose don Chisciotte, né manco ho avuto fame e neppure animo a questo. — E gli incantati mangiano essi? dimandò il giovane. — Né mangiano, rispose don Chisciotte, né servono ad altre necessità, tuttoché siavi opinione che crescano loro le ugne, la barba e i capelli. — E dormono almanco gl'incantati? dimandò Sancio. — Guardi Dio, rispose don Chisciotte: e certamente che nei tre giorni che siamo insieme vissuti laggiù nessuno chiuse mai occhio. — Oh adesso quadra bene il proverbio, soggiunse Sancio: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se vossignoria va colla gente incantata che non mangia e non dorme, è egli poi gran miracolo se sta digiuno e vigilante quando convive con loro? Oh mi perdoni la signoria vostra, signore e padron mio, ma io protesto, che Dio mi porti (e poco è mancato che non dicessi il diavolo) di non creder niente affatto di tutte le imposture che vossignoria ha raccontate sino a questo momento. — Come no? disse il giovane. Mentirebbe egli il signor don Chisciotte? anche volendolo, non avrebbe avuto campo di comporre ed immaginare questo milione di menzogne. — Io non intendo mica di voler dire che il mio padrone s'inventi menzogne, rispose Sancio. — Ma che credi tu dunque? lo interruppe don Chisciotte. — Credo, replicò Sancio, che quel Merlino e quegl'incantatori che incantarono tutta quella ciurmaglia che dice vostra signoria di aver veduto laggiù, e con cui asserisce di aver confabulato, abbiano messo nella stravolta sua fantasia tutta questa macchina a noi raccontata, e quella che resta ancora da udire. — Questa è cosa che potrebb'essere; ma pur non è, o Sancio, replicò don Chisciotte, avendo io veduto con questi occhi e toccato con queste mani quanto ho qui raccontato. Ma che sarai tu per soggiugnere, quando io ti assicurerò che fra le altre infinite e stupende cose mostratemi da Montésino (che già fra qualche tempo ed opportunamente durante il nostro viaggio ti andrò raccontando) mi fec'egli vedere tre contadine che per quelle amenissime campagne andavano saltando e dimenando le gambe come capre, e che non l'ebbi scoperte appena che conobbi essere una di esse la senza pari Dulcinea del Toboso, e le altre due quelle contadine medesime che a lei si accompagnavano e che noi trovammo all'uscire dal Toboso? Domandai a Montésino se le conosceva, e mi rispos'egli che no, ma figuravasi che fossero signore incantate, di molta nascita e distinzione, e diceva che da poco tempo soltanto erano comparse in quei prati. Aggiunse che non mi maravigliassi di questo, mentre quivi trovavansi molte altre matrone principalissime dei passati e presenti secoli, incantate in differenti e strane figure, fra le quali egli conosceva la regina Ginevra e la matrona Chintagnona, colei che mesceva il vino a Lancilotto, come dice il romanzo, allora che tornò di Brettagna.» Quando sentì Sancio dirsi questo dal suo padrone, fu per perdere il senno o per iscoppiare dalle risa, come quegli che ben sapeva il supposto incanto di Dulcinea, della quale era stato egli stesso l'incantatore e l'autore della falsità. Allora terminò di convincersi che il suo padrone perduto il giudizio, era diventato pazzo dichiarato, e quindi gli disse: — In mala congiuntura, in pessima occasione e in giorno di mal augurio calò vossignoria, mio caro padrone, all'altro mondo, e s'incontrò in mal punto col signor Montésino che l'ha concio in questa maniera. Ella stava in questo mondo fra noi col suo buon giudizio, tal quale glielo concesse Domeneddio, sputando sentenze e dando ad ogni poco consigli, ma adesso ci va infilzando spropositi che non sono credibili né immaginabili. — Siccome io ti conosco, o Sancio, rispose don Chisciotte, così non fo alcun conto delle tue parole. — Né io tampoco di quelle di vossignoria, replicò Sancio; e mi ferisca pure o mi ammazzi per quelle che ho dette, o per quelle che penso di dire, ma è certo che ella ha bisogno di convertirsi e di ravvedersi. E poi dicami vossignoria, ora che siamo in pace: come e con quali contrassegni conobbe ella la signora Dulcinea nostra padrona? E se le ha parlato, che disse e che le rispose? — Io l'ho conosciuta dal vestito, rispose don Chisciotte, ch'era quello medesimo che portava quando tu me l'hai fatta vedere; le ho parlato, ma non mi rispose sillaba, anzi mi voltò le spalle, e si mise a fuggire con tanta velocità che non l'avrebbe raggiunta una freccia. Volli seguitarla, e fatto lo avrei se Montésino non me ne avesse sconsigliato, sì perché vano sarebbe riuscito ogni mio sforzo ad arrivarla, sì perché si avvicinava il momento ch'io dovea uscire della grotta. Mi disse pure che coll'andare del tempo mi avrebbe reso avvertito del modo con cui dovessero essere disincantati egli, Belerma, Durandarte e gli altri tutti che quivi stavano. Ciò per altro che mi diede maggior fastidio tra le tante cose da me vedute e notate, si fu che facendo questo discorso con Montésino, si avvicinò a me da un lato, e senza ch'io mi accorgessi della sua venuta, una delle due compagne della sventurata Dulcinea, e cogli occhi pieni di lagrime, tutta conturbata, e con bassa voce così si espresse: La mia signora Dulcinea del Toboso bacia le mani a vossignoria, e la supplica istantemente di darle avviso come vossignoria sta; e per ritrovarsi in gran bisogno la supplica ancora di volerle prestare sopra questo gammurino di bambagina nuova, che ho qui, una mezza dozzina di reali, o quello che vossignoria si trovasse avere, ch'ella le dà parola di renderglieli al più presto che potrà. Questa ambasciata mi fece restare sospeso ed attonito e voltomi al signor Montésino gli dissi: Č egli possibile signor Montésino, che gli incantati di alto grado soffrano de' bisogni? E mi rispos'egli: Credami la signoria vostra, signor don Chisciotte della Mancia, che quello ch'è chiamato bisogno si trova in ogni parte e da per tutto si estende, e arriva a tutti, né la perdona agli incantati medesimi. Poiché dunque la signora Dulcinea del Toboso manda a chiederle questi sei reali, e il pegno (per quanto pare) è buono, non vi è che darglieli senza pensar ad altro; ché senza dubbio dee ella trovarsi in molto grandi strettezze. Non mi toglierò io già 'l pegno, gli risposi, né le darò ciò che chiede, non avendo meco che soli quattro reali (e furono quelli che tu Sancio, mi hai dato l'altro giorno per fare limosina a' poverelli che si trovavano per le strade), e allora dissi: Amica mia, fate sapere alla vostra che mi dolgono sino al cuore le sue angustie, dalle quali se fossi uomo ricco vorrei liberarla; ditele inoltre che non saprei né potrei godere della salute se restassi privo della deliziosa sua vista e della sua savia conversazione, e che la supplico quanto posso vivamente, che piaccia a sua signoria di lasciarsi vedere e trattenere da questo suo prigioniero servidore e angustiato cavaliere; le direte pur anche che quando meno se lo penserà, sentirà dire ch'io feci giuramento e voto, allo stesso modo di quello che fu fatto dal marchese di Mantova, il quale per vendicar suo nipote Baldovino quando lo trovò spirante in mezzo a quella montagna, non volle mangiare a tavola apparecchiata, con le altre circostanze occorrenti fino alla vendetta. Così farò anch'io e protesto di non posar mai e di scorrere le sette parti del mondo con esattezza maggiore della usata dall'infante don Pietro di Portogallo, e ciò fino al punto in cui mi sarà riuscito di trarla d'incanto. Tutto questo e più ancora è vossignoria in obbligo di fare per la mia padrona, mi disse la donzella; e presisi i quattro reali, in luogo di lasciarmi con una riverenza fece una capriola con cui balzò in aria per due braccia e volò via.
— Tu parli, o Sancio, a tal modo, disse don Chisciotte, perché mi ami, e perché non hai sperienza degli affari del mondo: tutte le cose che si presentano a te come difficili, ti sembrano impossibili, ma tempo verrà, come ti ho già detto, che t'informerò delle maraviglie da me viste laggiù, ed esse ti condurranno a prestar fede a quelle che ti ho raccontato, la cui verità non può ammettere replica od opposizione.» |

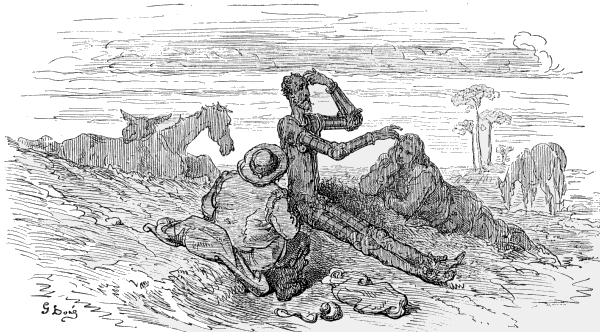
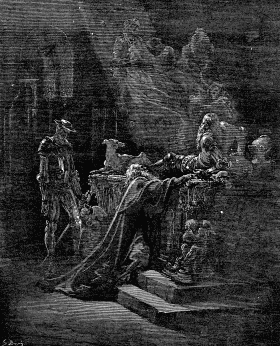 — Già, signor Durandarte, carissimo cugino mio,
già eseguito ho il comando che mi avete dato nel malaugurato giorno della vostra perdita.
Io vi trassi il cuore nel miglior modo che per me si è potuto, senza che ve ne restasse
la più picciola parte nel petto; l'ho ripulito io stesso con molta diligenza adoperando
un fazzoletto fornito di merli di punto, e me ne andai con esso di carriera verso la
Francia, avendovi prima posto in seno alla terra e sepolto con tante lagrime che bastarono
a lavarmi le mani ed a mondarmi del sangue che le bruttava per avere maneggiato le vostre
viscere. Per più indubitati contrassegni, o cugino dell'anima mia, sappiate che nel primo
luogo in cui mi avvenni uscendo di Roncisvalle, posi un po' di sale su questo vostro
cuore, affinché non putisse, e si conservasse se non fresco, almeno non stantìo alla
presenza della signora Belerma. Questa vostra diva e voi e me e Guadiana vostro scudiere e
la matrona Ruidera e le sue sette figlie e nipoti e molti altri vostri conoscenti siamo
qui, come sapete, tutti da tanti anni incantati dal mago Merlino: e benché ne siano già
passati da cinquecento, pure non è tuttavia morto alcuno di noi, e mancano soltanto
Ruidera e le sue figlie e i nipoti. Ora saprete che queste piangendo, per compassione
ch'ebbe Merlino di loro, sono adesso convertite in altrettante lagune, che al mondo dei
viventi e nelle provincie della Mancia si chiamano tuttavia le Lagune di Ruidera: le sette
sono dei re di Spagna, e le due nipoti dei cavalieri di un ordine santissimo, detto
l'Ordine di san Giovanni: anche Guadiana vostro scudiero, piangendo egli ancora la
fatalità vostra fu tramutato in un fiume che porta il suo medesimo nome; e questo quando
giunse alla superficie della terra e vide il sole dell'altro cielo ebbe tanto affanno in
lasciarvi che si sommerse nelle viscere della terra: ma siccome non lascerebbe giammai di
seguitare la naturale sua corrente, di tanto in tanto esce e sormonta per essere veduto
dal sole e dalle genti. Gli somministrano le loro acque le riferite lagune, in grazia
delle quali e di altre molte che se gli aggiungono, entra in Portogallo pomposo e grande:
ma ad onta di tutto questo, ovunque egli percorre mostra la tristezza e la malinconia che
lo ingombra, né si pregia di alimentare nelle sue onde pesci squisiti e singolari, ma
lucci sciocchi ed insipidi e diversi totalmente da quelli del Tago dorato. Quello che ora
vi dico, cugino mio, molte volte vel ripetei, ma non avendo da voi mai avuta risposta mi
vo figurando che non mi prestiate fede o non mi udiate; di che se io porti viva amarezza
nell'animo sallo Iddio! Ora vi aggiungerò altre novelle che se non potranno alleggerire
il vostro dolore, non lo accresceranno almeno. Sappiate che sta qui presente al cospetto
vostro (aprite gli occhi e 'l vedrete) quel gran cavaliere di cui tante cose ha
profetizzato il mago Merlino, quel don Chisciotte della Mancia, il quale io so che di
nuovo e con molto maggior eccellenza che nei passati secoli ha risuscitato al presente la
già obbliata errante cavalleria. Potrebbe avvenire che per suo mezzo e per il suo favore
noi fossimo tratti d'incantesimo, da che le grandi imprese ai grandi uomini soltanto son
riserbate
— Già, signor Durandarte, carissimo cugino mio,
già eseguito ho il comando che mi avete dato nel malaugurato giorno della vostra perdita.
Io vi trassi il cuore nel miglior modo che per me si è potuto, senza che ve ne restasse
la più picciola parte nel petto; l'ho ripulito io stesso con molta diligenza adoperando
un fazzoletto fornito di merli di punto, e me ne andai con esso di carriera verso la
Francia, avendovi prima posto in seno alla terra e sepolto con tante lagrime che bastarono
a lavarmi le mani ed a mondarmi del sangue che le bruttava per avere maneggiato le vostre
viscere. Per più indubitati contrassegni, o cugino dell'anima mia, sappiate che nel primo
luogo in cui mi avvenni uscendo di Roncisvalle, posi un po' di sale su questo vostro
cuore, affinché non putisse, e si conservasse se non fresco, almeno non stantìo alla
presenza della signora Belerma. Questa vostra diva e voi e me e Guadiana vostro scudiere e
la matrona Ruidera e le sue sette figlie e nipoti e molti altri vostri conoscenti siamo
qui, come sapete, tutti da tanti anni incantati dal mago Merlino: e benché ne siano già
passati da cinquecento, pure non è tuttavia morto alcuno di noi, e mancano soltanto
Ruidera e le sue figlie e i nipoti. Ora saprete che queste piangendo, per compassione
ch'ebbe Merlino di loro, sono adesso convertite in altrettante lagune, che al mondo dei
viventi e nelle provincie della Mancia si chiamano tuttavia le Lagune di Ruidera: le sette
sono dei re di Spagna, e le due nipoti dei cavalieri di un ordine santissimo, detto
l'Ordine di san Giovanni: anche Guadiana vostro scudiero, piangendo egli ancora la
fatalità vostra fu tramutato in un fiume che porta il suo medesimo nome; e questo quando
giunse alla superficie della terra e vide il sole dell'altro cielo ebbe tanto affanno in
lasciarvi che si sommerse nelle viscere della terra: ma siccome non lascerebbe giammai di
seguitare la naturale sua corrente, di tanto in tanto esce e sormonta per essere veduto
dal sole e dalle genti. Gli somministrano le loro acque le riferite lagune, in grazia
delle quali e di altre molte che se gli aggiungono, entra in Portogallo pomposo e grande:
ma ad onta di tutto questo, ovunque egli percorre mostra la tristezza e la malinconia che
lo ingombra, né si pregia di alimentare nelle sue onde pesci squisiti e singolari, ma
lucci sciocchi ed insipidi e diversi totalmente da quelli del Tago dorato. Quello che ora
vi dico, cugino mio, molte volte vel ripetei, ma non avendo da voi mai avuta risposta mi
vo figurando che non mi prestiate fede o non mi udiate; di che se io porti viva amarezza
nell'animo sallo Iddio! Ora vi aggiungerò altre novelle che se non potranno alleggerire
il vostro dolore, non lo accresceranno almeno. Sappiate che sta qui presente al cospetto
vostro (aprite gli occhi e 'l vedrete) quel gran cavaliere di cui tante cose ha
profetizzato il mago Merlino, quel don Chisciotte della Mancia, il quale io so che di
nuovo e con molto maggior eccellenza che nei passati secoli ha risuscitato al presente la
già obbliata errante cavalleria. Potrebbe avvenire che per suo mezzo e per il suo favore
noi fossimo tratti d'incantesimo, da che le grandi imprese ai grandi uomini soltanto son
riserbate Voltosi allora ad un altro lato tornò all'usato
silenzio, né proferì più sillaba alcuna. Grandi ululati e compianti, accompagnati da
profondi gemiti e da angosciosi singhiozzi eccheggiarono in quel punto per tutta la
Grotta, ed io voltai la testa, e vidi attraverso le cristalline pareti, come per altra
sala passava maestosa processione di due fila di bellissime donzelle, tutte vestite a
lutto e con turbanti bianchi in testa alla foggia turchesca. A capo di quelle due schiere
veniva illustre donna; ché tale rassembrava al portamento vestita pur essa di bruno, con
veli bianchi sì distesi e lunghi che si trascinavano sul suolo. Il turbante che ella
portava era due volte maggiore del più grande di tutti gli altri; aveva le ciglia
incrocicchiate, il naso un po' infranto, grande la bocca, ma rosse le labbra, e i denti
che talvolta scopriva mostravano di essere radi e non bene commessi, tuttoché bianchi
come lisce mandorle. Teneva in mano un sottil fazzoletto, entro cui, per quanto si poté
scorgere, stava un cuore di carne mummificato; tanto era secco e annerito! Montésino mi
disse che tutta la gente che componeva quella processione erano serventi di Durandarte e
di Belerma, le quali ivi coi due loro padroni stavano incantate come tutti gli altri; e
che l'ultima, la portatrice del cuore nel fazzoletto, era la signora Belerma, che per
quattro giorni di ogni settimana colle sue donzelle faceva quella processione, cantando o
per meglio dire, piangendo versi di mestizia sulla spoglia e sul compassionevole cuore del
suo cugino. Mi avvertì ancora che se a me fosse apparsa un po' brutta, o non così bella
come ne correva il grido, se ne doveano incolpare le triste notti e i dì peggiori ch'ella
passava in quell'incantamento, come lo dimostravano le sue grandi occhiaie e il suo colore
gialliccio. Se l'affanno del suo cuore, mi disse, che sempre le ricorda la fatal perdita
del suo amante nel fiore degli anni, non la amareggiasse, l'agguaglierebbe appena in
bellezza, in grazia e in bel garbo la grande Dulcinea del Toboso, sì celebrata per tutti
questi contorni ed anche per tutto il mondo.
Voltosi allora ad un altro lato tornò all'usato
silenzio, né proferì più sillaba alcuna. Grandi ululati e compianti, accompagnati da
profondi gemiti e da angosciosi singhiozzi eccheggiarono in quel punto per tutta la
Grotta, ed io voltai la testa, e vidi attraverso le cristalline pareti, come per altra
sala passava maestosa processione di due fila di bellissime donzelle, tutte vestite a
lutto e con turbanti bianchi in testa alla foggia turchesca. A capo di quelle due schiere
veniva illustre donna; ché tale rassembrava al portamento vestita pur essa di bruno, con
veli bianchi sì distesi e lunghi che si trascinavano sul suolo. Il turbante che ella
portava era due volte maggiore del più grande di tutti gli altri; aveva le ciglia
incrocicchiate, il naso un po' infranto, grande la bocca, ma rosse le labbra, e i denti
che talvolta scopriva mostravano di essere radi e non bene commessi, tuttoché bianchi
come lisce mandorle. Teneva in mano un sottil fazzoletto, entro cui, per quanto si poté
scorgere, stava un cuore di carne mummificato; tanto era secco e annerito! Montésino mi
disse che tutta la gente che componeva quella processione erano serventi di Durandarte e
di Belerma, le quali ivi coi due loro padroni stavano incantate come tutti gli altri; e
che l'ultima, la portatrice del cuore nel fazzoletto, era la signora Belerma, che per
quattro giorni di ogni settimana colle sue donzelle faceva quella processione, cantando o
per meglio dire, piangendo versi di mestizia sulla spoglia e sul compassionevole cuore del
suo cugino. Mi avvertì ancora che se a me fosse apparsa un po' brutta, o non così bella
come ne correva il grido, se ne doveano incolpare le triste notti e i dì peggiori ch'ella
passava in quell'incantamento, come lo dimostravano le sue grandi occhiaie e il suo colore
gialliccio. Se l'affanno del suo cuore, mi disse, che sempre le ricorda la fatal perdita
del suo amante nel fiore degli anni, non la amareggiasse, l'agguaglierebbe appena in
bellezza, in grazia e in bel garbo la grande Dulcinea del Toboso, sì celebrata per tutti
questi contorni ed anche per tutto il mondo. —
Buon Dio! buon Dio! sclamò Sancio, è egli dunque possibile che sienvi tali cose al mondo
di là, e che abbiano tanta forza gl'incantatori e gl'incantesimi da condurre il mio
padrone a perdere affatto il giudizio e a dare in sì spropositate pazzie? Ah signore,
signore, io la prego e la scongiuro di stare meglio sopra se stesso, e di tornare in sé
per lo suo proprio decoro, e di non credere a tante balordaggini che le hanno affatto
guasto e scemo il cervello.
—
Buon Dio! buon Dio! sclamò Sancio, è egli dunque possibile che sienvi tali cose al mondo
di là, e che abbiano tanta forza gl'incantatori e gl'incantesimi da condurre il mio
padrone a perdere affatto il giudizio e a dare in sì spropositate pazzie? Ah signore,
signore, io la prego e la scongiuro di stare meglio sopra se stesso, e di tornare in sé
per lo suo proprio decoro, e di non credere a tante balordaggini che le hanno affatto
guasto e scemo il cervello.