|
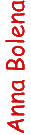
|
|
|
Claudio Casini
ANNA BOLENA NEL SUO
CONTESTO STORICO-MUSICALE
|
| Due sovrani assoluti, Rossini e Verdi, regnarono sull'Italia operistica, succedendosi l'uno all'altro, nell'Ottocento. Ma vi fu un interregno, ed esso venne spartito fra diadochi maggiori e minori: Donizetti, Bellini, Mercadante, Pacini e altri più piccoli, talvolta minimi baroni. La loro attività culminò da quando Rossini, trasferendosi a Parigi, depose lo scettro d'Italia intorno al 1824, dopo «La Semiramide», a quando Verdi lo raccolse d'autorità nel 1842, dopo Nabucco. |
| Donizetti fu il più attivo non soltanto per il grande numero d'opere che scrisse, ma anche per gli irreversibili cambiamenti da lui introdotti nel melodramma. Pur osservando la struttura imposta da Rossini, la trasformò in qualcosa di nuovo e di più congeniale allo spirito del 1830. Lo si può anche definire spirito romantico nei limiti concessi al romanticismo da una Italia legata ad ancestrali idee di classicità. |
| Nel corso di un'attività senza soste, perfino frettolosa e generica, Donizetti ebbe il lampo di genio, l'intuizione, di cogliere e di interpretare le inevitabili evoluzioni della società italiana. Le rispecchiò, non sempre e non spesso, nel suo teatro. La sua presenza, affiorata alI'epoca del fulgore di Rossini, cessò ai tempi del giovane Verdi; e fu una presenza decisiva, che contribuì a creare una situazione nuova, in cui sarebbe stato concesso al compositore di trasformarsi in drammaturgo, abbandonando la vecchia funzione di inventare, nell'opera seria, allegorie musicali sistemate secondo le categorie e i cataloghi antiquari delle passioni tragiche. |
| «Anna Bolena», nel 1830, segnò appunto la frattura tra vecchio e nuovo. |
| Pochi vissero, al pari di Donizetti, il mestiere di operista italiano con tutti i compromessi, le alee e le fatiche che esso implicava. Si trattava di un mestiere in cui il fare, spesso, non dava il tempo di pensare. |
| Richiedeva un'accurata preparazione didattica, da compiere nell'adolescenza e in breve tempo, grazie ad innate qualità di apprendere, adatte ad accorciare i tempi di attesa. Si doveva meritare il successo da giovani, se non da giovanissimi come Rossini, per sfuggire alla mediocrità di un decoroso professionismo. Nel caso di Donizetti, per mettere adeguato spazio fra sé e il malinconico scantinato di Bergamo in cui era nato. |
| Una volta raggiunto il primo successo, iniziava una frenetica produzione destinata alle principali città della penisola, tenendo dietro alle scadenze rituali delle stagioni liriche, alla dispo nibilità delle compagnie di canto, alle possibilità degli impresari e, soprattutto, ai gusti di ogni città: Venezia non aveva gli stessi gusti di Napoli, né Roma quelli di Milano. Un operista affermato ne doveva tener conto, e non poteva permettersi di trascurare alcuna città, pena il calo delle proprie quotazioni. Il teatro musicale italiano funzionava come una moderna borsa dei valori azionari, in cui la presenza deve essere costante e gli exploits sempre al massimo. |
| E ancora: nel corso di questa frenetica attività, l'operista doveva trovare l'occasione di scrivere qualche capolavoro, in maniera da ottenere repliche di una stessa opera in differenti città. Era l'unico modo, a parte il vantaggio di conquistare i primi posti, per alleviare la fatica di essere sempre e comunque presente. Le repliche erano rare, in confronto alle esigenze di novità. |
| Infine: occorreva saper alternare opere di genere tragico e di genere comico, visto che l'alternativa era gradita al pubblico. Quanto più un operista era capace nei due generi, tanto maggiore spazio gli era riservato nei teatri. |
| Nell'insieme, il lavoro di operista dipendeva da un'organizzazione teatrale frammentaria. Vi trionfava l'iniziativa privata degli impresari che, con le loro richieste tutte per le stesse scadenze e in tempi brevi, mettevano a dura prova la resistenza dei librettisti, dei compositori e dei cantanti. Si era ben lontani dalla stabilità dei teatri sovvenzionati di Parigi, di Londra e della Germania, dove le occasioni erano minori, ma le cui più tranquille gestioni favorivano una più meditata qualità delle opere in cartellone. |
| Donizetti, ricevuta una buona istruzione da due autentici maestri, Simon Mayr nella città natale di Bergamo, e il padre Stanislao Mattei nella dotta (anche per la musica) Bologna, si inserì volonterosamente nell'attività teatrale italiana, in cui tutto doveva esser creato all'istante, e realizzato in maniera provvisoria. Vent'anni dopo, per molto meno, il giovane Verdi avrebbe dichiarato quasi forfait, dopo il mezzo successo di «Oberto» e l'insuccesso di «Un giorno di regno», prima di riprendersi e di proseguire con «Nabucco», non senza molti lamenti e qual che certificato medico che lo liberasse ogni tanto dal superlavoro. |
| Si sa invece come fini Donizetti, minato nella salute fisica e in quella mentale proprio dall'eccesso di fatica intellettuale e dalla sregolatezza di un'attività convulsa. Qualche volta anch'egli si lamentava, ma in definitiva una simile frenesia era fatta per il suo carattere: «Sai la mia divisa? Presto! Può essere biasimevole, ma ciò che feci di buono, è sempre stato fatto presto». |
| Al pubblico piacevano anche molto le competizioni fra cantanti e fra compositori. Accadde così che una delle prime opere notevoli di Donizetti, «Anna Bolena», apparisse al Teatro Carcano di Milano, il 26 dicembre 1830, come prima battuta cui sarebbe sarebbe seguita, il 6 marzo 1831, la risposta di Bellini, con «La Sonnambula». Stesso librettista, Felice Romani, e stessi interpreti principali, il soprano Giuditta Pasta e il tenore Giovanni Battista Rubini, nelle due opere. Si trattava del miglior cast allora disponibile in Italia. |
| Il confronto tra Bellini e Donizetti, d'altra parte, non era nuovo. Era avvenuto già tre anni prima, a Genova, per l'inaugurazione del teatro Carlo Felice. Era stata addirittura una competizione triangolare, fra Bellini con la riedizione di «Bianca e Fernando», Donizetti con «Alina, regina di Golconda» e Francesco Morlacchi (nativo di Perugia, allievo di Zingarelli, addetto al teatro italiano di Dresda, alla corte di Sassonia) con «Il Colombo». |
| Ad «Anna Bolena», Donizetti arrivava reduce da una già ragguardevole carriera. Ma era stata una carriera da inattuale, rispetto a quella del molto più cauto e calibrato Bellini. Questi aveva composto poche opere, di genere drammatico, ed aveva instaurato un'opportuna collaborazione col librettista principe del momento, Felice Romani. Donizetti ne aveva composte molte, di vario tipo, su libretti d'occasione. Nell'adeguarsi alle convenzioni teatrali e anche al proprio carattere incline all'attivismo aveva proseguito i modelli settecenteschi, ché tuttavia Rossini aveva superato. |
| Modello principale, per Donizetti, era stato quello del compositore abile ad affrontare tutti i generi teatrali, dalla farsa all'opera comica, dall'opera seria alla semiseria, senza eccezioni se non quelle della committenza impresariale e dei gusti provinciali da soddisfare. |
| Nei dodici anni precedenti «Anna Bolena» (il debutto era avvenuto nel 1818 a Venezia) aveva composto di tutto e con tutti, anche sedici quartetti per archi che si possono considerare frutto della sua buona istruzione musicale. |
| Aveva esordito a Venezia con quattro opere su libretto di Bartolomeo Merelli, il quale avrebbe abbandonato la penna per diventare un celebre impresario; a Roma si era fatto conoscere favorevolmente, ed aveva trovato, per «L'ajo nell'imbarazzo», miglior librettista in Jacopo Ferretti, l'autore della «Cenerentola» per Rossini. |
| Poi era caduto in balìa di due autori napoletani, succedutisi nella carica di poeta ufficiale del teatro San Carlo: Leone Tottola e Domenico Gilardoni. Da loro era stato assistito quasi in tutta la produzione per Napoli, ivi inclusa l'azione tragico-sacra ll diluvio universale in cui, come già un tempo Rossini con Mosé, aveva esaudito il gusto dei napoletani per un simile genere di spettacolo, caratteristico della Quaresima. Infine aveva adoperato un libretto di Romani, «Chiara e Serafina» per l'esordio a Milano nel 1822. In verità, senza esito degno del celebre librettista. |
| Nel corso di quei dodici anni, però, Donizetti aveva già conosciuto un'evoluzione del proprio stile. Era partito da un generico e sonnolento settecentismo, tipico dei maestri provinciali italiani nel primissimo Ottocento, per arrivare ad elevarsi all'imitazione di Rossini, considerato un audace innovatore. Ciò testimoniava la volontà di aggiornarsi e di progredire, abbandonando anche gli atteggiamenti togati della tragédie-lyrique francese, nota in Italia, e specialmente nella Napoli infranciosata durante il regno bonapartista di Murat, grazie alla traduzione delle opere di Spontini. |
| L'incontro con Felice Romani, per «Anna Bolena», segnò un'ulteriore svolta e, in certa misura, una scoperta di se stesso. Non irreversibile, come dimostrò la successiva produzione donizettiana, soggetta a ricadute nel generico; ma non senza seguito, stando ai capolavori degli anni seguenti. |
| Felice Romani godeva di grande reputazione tanto come letterato quanto come librettista. La meritò perché stava compiendo una piccola rivoluzione nei libretti operistici, nei quali conciliava decoro letterario, nozioni aggiornate di drammaturgia e tecnica adatta al melodramma. Malgrado fosse un classicista e un seguace di Vincenzo Monti, la vocazione per le forme nitide e razionalizzate non gli impediva di accogliere accenti nuovi, in qualche modo legati al romanticismo. Era accaduto, d'altra parte, al Monti poeta e anche drammaturgo, autore di Galeotto Manfredi e di Caio Gracco. |
| In realtà, il classicismo di Romani continuò a manifestarsi nel lessico e nella metrica, ancora metastasiani; per il resto, la condotta dell'azione, il plot, si allontanavano dagli schemi antiquari dell'opera seria, anche se Bellini e Gaetano Rossi li avevano rimessi alla moda, nel 1823, con «La Semiramide». Romani, da classicista illuminato, andava fondendo il nitore della forma letteraria con la casistica di una drammaturgia attuale. Conciliare passato e presente era, ed è, un costume molto apprezzato nella cultura italiana: non mancò di procurare a Romani il plauso dei letterati e il consenso del pubblico, il favore dei musicisti e i contratti degli impresari. |
| Questo nuovo orientamento era già evidente nei libretti redatti prima del 1830, e si sarebbe sviluppato in seguito, a partire da «Anna Bolena». Al posto di eroi storici e mitici della classicità, consueti nell'opera seria d'altri tempi, nei libretti di Romani si cominciarono a trovare personaggi d'invenzione, ricavati dalla narrativa romantica straniera, ad esempio quelli del «Pirata», della «Straniera», della «Sonnambula», o ripresi dallo Shakespeare ammirato dai romantici, ad esempio Romeo e Giulietta nei «Capuleti e i Montecchi». In seguito, anche se sarebbe tornato alla tragedia classica con «Norma», Romani si spinse fino al teatro rivoluzionario di Hugo, con «Lucrezia Borgia», e alla commedia borghese parigina di Scribe, con «L'elisir d'amore». |
| Con il mutarnento dei soggetti, mutò il codice drammaturgico. I temi tragici nascevano da conflitti di natura intimista, ben comprensibili agli spettatori borghesi del primo Ottocento italiano. |
| Romani non metteva più in scena, come si faceva in passato, astratti furoni tipici di una tematica aristocratica: ragion di stato, guerra, tradimento politico, impegni dinastici. O se li metteva in scena, erano presi in considerazione per il loro aspetto privato, per le loro ripercussioni sentimentali. Inoltre, I'azione non doveva più concludersi con il finale edificante, in cui la virtù risulta premiata e la malvagità è punita, secondo la regola aristotelica della catarsi, vigente ancora nell'opera seria; al contrario, e «Anna Bolena» ne è un buon esempio, l'azione si conclude con il soggiacere dei deboli e dei buoni alla volontà e alla prevaricazione dei forti e dei malvagi. |
| Il dramma di «Anna Bolena» non è soltanto di natura privata, a parte il fatto che sia ambientato in una corte regale e che i personaggi portino i nomi illustri dell'aristocrazia inglese. È un dramma in cui appare un tema attuale nella società borghese ottocentesca: la crisi dei rapporti coniugali e il divorzio, con il loro corollario costituito dalla posizione di inferiorità femminile. |
| L'azione si concentra sull'innocenza di Anna Bolena: vilipesa dal ripudio di Enrico VIII; conculcata dalla verosimiglianza dei sospetti sul suo adulterio col paggio Smeton e con Lord Percy; tradita da una dama della sua stessa corte, Giovanna Seymour, a sua volta incapace di respingere la passione di Enrico VIII; delusa per aver preferito, a suo tempo il matrimonio col re fedifrago anziché l'amore di Percy. |
| Con Anna Bolena, gli altri personaggi intrattengono relazioni ben precise: di malevolenza, da parte di Enrico VIII, deciso ad ucciderla, per quella norma che consiglia di infierire sulle vittime, di amore, da parte di un Lord Percy inutilmente protettivo, visto che contribuisce poi, con la sua fiera confessione, a trascinare Anna in un'assurda ribellione al re; ancora di amore, ma non ricambiato da parte di Smeton, che si rivela addirittura rovinoso con la sua cieca passione; di rimorso, da parte della Seymour, in cui Anna vede un suo doppio, una se stessa di anni prima, all'inizio del rapporto con Enrico VIII che aveva ripudiato Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena, mettendola nel ruolo che adesso è di Giovanna Seymour. |
| Si tratta di una serie di relazioni dalle quali nasce un codice molto vicino alla sensibilità borghese, ai sentimenti di amore coniugale e di amore adulterino (vale a dire, leciti o illeciti), di onore, di pietà, di cordoglio, tipici di una società abituata a rispecchiarsi nella realtà romanzesca della narrativa romantica, da Scott a Chateaubriand, da Stendhal a Byron. |
| Con il cambiamento di soggetto e con la trasformazione del codice drammatico, rispetto al passato, Romani mutò anche la condotta delI'azione. Adottò un sistema episodico, in cui erano illustrate le relazioni di ogni personaggio con la protagonista, e di alcuni personaggi fra loro, senza troppo preoccuparsi se il taglio della sccneggiatura procedeva per scorci, talvolta per successioni ellittiche, invece che per sequenze concatenate. In «Anna Bolena», scorci ed ellissi abbondano. |
| Il dramma viene impostato, nell'introduzione, sul clima turbato della corte, intorno ad Anna Bolena; ma subito dopo si sposta sul confronto fra la riluttante Seymour e il re. Quindi, le due scene successive introducono altri personaggi, Percy e Smeton (apparso soltanto come clemento decorativo, con la sua ballata nell'introduzione), ambedue innamorati di Anna. Queste scene sviluppano aspetti differenti del dramma: l'agnizione di Anna e Percy, le accuse pubbliche del re contro Anna. |
| Un passaggio ellittico, al secondo atto, conduce all'ultima parte del dramma, il quale a sua volta procede ancora per scorci: Anna in carcere, compianta dalle damigelle; Anna a confronto con la pentita Seymour; Anna ribelle al re, insieme con Percy e, dopo un patetico solo di Percy, follia e morte di Anna. È da notare come una possibile scena di insieme, il giudizio contro Anna, sia omessa, così come si dà per scontato lo svolgimento dell'intrigo che, fra primo e secondo atto, ha avuto l'effetto di far imprigionare Anna. |
| Si tratta di una condotta del libretto quanto mai adatta alla distribuzione di entrate fra i cantanti, all'economia dello spettacolo, alla concisione e varietà della musica, onde non insistere troppo sulle stesse situazioni sceniche o «posizioni», come si diceva allora. |
Un simile andamento succinto perfetto in un libretto per musica, era particolarmente adatto a Donizetti e al suo far «presto».
Presto non era, per Donizetti, soltanto un riIerimento ai tempi di lavoro, ma anche e sopr attutto un moto relativo alla sua concezione dcl melodramma. Presto significava movimento in scena, emozione nella musica, concitazione nella vocalità, toccando in maniera rapida e penetrante gli episodi del dramma, facendone vibrare tutte le corde, dalla tragedia all'elegia. |
| Donizetti non arrivava alla concezione della musica come espressione organica e totale del dramma, riservata in futuro a Verdi; ma si distaccò dalla mentalità settecentesca di considerare la musica come espressione di stati d'animo catalogati secondo astratte categorie, da giuocare nei meccanismi di libretti ancora sovrastati dai modelli di Metastasio. Compì unpasso decisivo nella direzione indicata da Rossini con «Otello»; ma non vi si inoltrò fino al punto d'arrivo del dramma musicale. Un punto d'arrivo abbastanza lontano da impegnare Verdi per quasi tutta la sua carriera. |
Il luogo di Donizetti è intermedio fra i due estremi del passato e dell'avvenire; ma è un suo luogo caratteristico, anche se ristretto al punto di far inclinare il suo stile, ad ogni piccolo spostamento, verso l'eredità rossiniana o ver-
so un futuro non ancora ben definito. Questo luogo è la scena ad alta intensità drammatica. |
| In «Anna Bolena» ce n'è una: il terzetto di Anna, Percy ed Enrico VIII. Nel suo svolgimento, vengono cancellati i limiti tradizionali fra la parte attiva dell'azione, il recitativo, e la parte contemplativa, l'ensemble affidato alla forma strofica del canto. L'intero pezzo è concepito come un organismo completo e particolareggiato, in cui si fondono i compiti propri di ogni parte dello schema tradizionale: il movimento narrativo ed emozionale della musica introduce la concitazione del recitativo nell'ensemble, scardinandone la staticità lirica convenzionale; per contro, il recitativo accoglie punte liriche di grande rilievo, nella frammentazione e negli scatti di una vocalità realistica. |
| In questo passo di Anna Bolena, Donizetti ha inventato una nuova dinamica nella melodia e nel canto del melodramma italiano. E un valore assoluto. Verdi, rispetto alla penetrante drammaticità di questa invenzione donizettiana, partì da posizioni più arretrate e ne recuperò il significato dopo anni, in Ernani. |
| Come spesso accade, un valore assoluto non resta inerte all'interno di un'opera d'arte. In qualche misura, anche se è incastonato in materiali di qualità inferiore, la sua luce si riverbera su di essi. Sotto questo aspetto, alcuni brani di «Anna Bolena» riflettono la drammaticità rapida concisa del terzetto: esso si colloca come un momento culminante verso il quale sono orientati i precedenti, vale a dire il duetto di Giovanna e di ,Enrico VIII, il quintetto, il finale primo, il I duetto di Anna e di Giovanna, e dal quale dipende, come un'elegia, il patetismo della conclusiva follia di Anna. |
| In tutti questi passi, e in alcuni più brevi sparsi nella partitura, dove si acuisce lo svolgimento del dramma il recitativo e il canto strofico dei pezzi chiusi si integrano fra loro e, anche senza toccare il livello di intensità del terzetto, registrano con sensibilità le vibrazioni drammatiche dell'azione. |
| Altrove, la presentazione del personaggio si concreta in entrate vocalistiche durante le quali un profilo psicologico, una condizione umana, vengono fissate nel pezzo solistico, secondo una tradizione accettata. È un'eredità del teatro tragico ma anche una necessità di natura drammatica: in tal caso, malgrado la convenzione, la melodia di Donizetti rispecchia un punto intermedio fra tradizione e novità. Non con l'autorevolezza data dalla scoperta di valori assoluti, ma con efficacia: tali le sortite di Giovanna e di Anna, di Percy e di Smeton, e le loro ripetizioni, per quanto riguarda Giovanna e Percy, nel secondo atto. |
| Infine, un rilievo non indifferente tocca al coro, tolto in almeno due punti dell'opera alle sue funzioni generiche, per assumere un ruolo preciso, di sapore classicista. In apertura e nel penultimo pezzo del secondo atto, Donizetti adoperò due sezioni di soprani per il compianto di Anna Bolena: una scelta timbrica, quella del coro femminile che testimonia una precisa dimensione patetica, in accordo con le intenzioni di Felice Romani, che si potrebbero anche intendere come una vera e propria estetica. |
| Ad un'analisi minuziosa della partitura, sarebbe da scoprire il rovescio della medaglia: vale a dire, i debiti di Donizetti con la tradizione, soprattutto quelli contratti con Rossini. In alcuni passi vocali si riconoscerebbe il calco rossiniano, in particolare l'impiego del virtuosismo in qualità di segnale tragico, secondo una convenzione che risaliva a tempi più antichi di Rossini, si attribuirebbe alla parte di contralto del paggio Smeton nostalgie per il registro acuto dei castrati settecenteschi, più che filiazioni dall'adolescente Cherubino di Mozart o presagi dell'Oscar di Verdi. |
| Su un piano più generale, si potrebbe fare un'osservazione sulle simmetrie delle frasi musicali, sull'obbligatoria cadenza che scandisce una metrica talvolta facile, talaltra puntigliosa. Si direbbe che non sia estraneo, a queste scansioni, un certo accademismo mutuato, ancora, da Rossini e perfino dai classici viennesi, auspice il maestro di Bergamo Simone Mayr. |
| Su questo piano, Donizetti in qualche momento si rivela più attento musicista che penetrante drammaturgo: quel tanto di professionale gli impedì di valicare esplicitamente le esigenze di una struttura codificata, per tentare di raggiungere esiti drammatici complessivi. |
| Non si può chiedere, tuttavia, al Donizetti del 1830 di essere qualcosa di diverso da ciò che gli consentivano la naturale evoluzione del melodramma italiano in quell'epoca e il suo personale sviluppo artistico. Da un lato, i limiti del gusto corrente impedivano a qualsiasi musicista, come lo impedirono più tardi a Verdi, di compiere passi più lunghi del dovuto, tanto meno di spingersi nella direzione di un'avanguardia artistica inaccettabile in Italia. D'altro lato, questi limiti coincidevano con la mentalità di Donizetti e con le sue possibilità, consentendogli esattamente ciò che egli poteva compiere, nel senso di un approfondimento della dimensione drammatica. |
| Appunto qui sta il pregio del teatro di Donizetti: nel dissidio fra l'osservanza della tradizione e l'urgenza di esprimere una realtà nuova. Un dissidio che non appartiene alla personalità umana del musicista, ma che egli avverte ed oggettiva nella sua arte, sì che le forme nitide e razionalizzate resistono, ma profondamente innervate da una nuova sensibilità. |
| Esattamente quanto bastava all una società in cui era avvenuto l'avvicendamento fra classi dominanti, dall'aristocrazia alla borghesia, ma in cui la forza nascente della borghesia era ancora dissimulata nell'inerzia politica e ideo Iogica. Al massimo, poteva esprimersi sotto forma di sogno artistico, nel melodramma. |
| Claudio Casini, «Anna Bolena», Programma del Teatro alla Scala, Stagione 1981/1982, pp. 48-57. |
 |

|
|
|