|
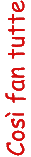
|
| |
I GRANDI DIRETTORI
E
«Così fan tutte»
|
| |
|
| |
Elvio Giudici
L'opera in CD e video. Guida all'ascolto.
[Milano, Il Saggiatore, 1995, pp. 789-796, passim.]
|
| |
|
| HERBERT VON KARAJAN
[DG 1955]

|
Nel suo unico incontro discografico con un'opera da allora mai più rientrata nel suo repertorio Karajan inquadra atmosfere sognanti, languide, stilizzatissime: che datano molto l'esecuzione, poco o punto consone come sono all'atmosfera concreta fino alla crudezza d'un'opera enigmatica, sì, ma pur sempre accidentata in contrasti sentimentali intessuti di crudeli ambiguità, qui viceversa del tutto assenti. La perfezione e la bellezza sonora cui Karajan perviene, alla guida di quello stupendissimo strumento sonoro che era la Philharmonia così come Legge l'aveva costruito elemento dopo elemento, sono tuttavia di qualità tanto alta da diventare esse stesse elemento teatrale: un teatro metafisico, simile a certe pitture del Novecento in cui stilizzate silhouettes intrecciano elegantissime movenze. |
| |
|
| KARL BÖHM
[DECCA1955 -
EMI 1962
DG 1974]

|
Il maggiore protagonista nell'operazione di rientro del «Così» nel repertorio corrente è sicuramente stato Böhm. Dell'opera, tuttavia, il maestro austriaco scorgeva precipuamente gli immensi tesori musicali, mai essendo colpito dai tratti incredibilmente moderni della sua struttura drammatica, trascurati in favore d'un'atmosfera lieve e spumeggiante, dove il riso prevaleva di gran lunga sul sorriso e l'amarezza del disincanto neppure veniva accennata. Una visione sicuramente incompleta, quindi - come tale, parecchio datata per le orecchie moderne - e in cui trovano la loro logica i tagli dissennati che affliggono quasi ogni numero dell'incisione Decca: tagli solo di poco alleggeriti, molti anni dopo, nel vivo delle recite salisburghesi, laddove la registrazione EMI ne pratica due soltanto (duetto Ferrando-Guglielmo «Al fato dan legge», aria di Ferrando «Ah lo veggio»). A fronte, abbiamo un rilievo e una messa in valore dei tratti più squisitamente musicali quale ben poche altre esecuzioni possono vantare.
Nel '62, tornando a incidere l'opera per la EMI e quindi sotto la supervisione di Walter Legge, se da un lato Böhm sembra accentuare certa propensione tedesca per un Mozart da trattare come una fragile porcellana sottovetro - e quindi distilla quasi con precauzione raffinatezze sonore fin sulla soglia del manierismo - dall'altra la maniacale cura di Legge nel sottolineare ogni infitesima sfumatura del fraseggio fa sì che il manierismo si concretizzi in misura cospicua per quanto concerne la Ludwig e la Steffek, intrida ogni nota del canto della Schwarzkopf, mentre - e la cosa stupisce poco - riguardi solo marginalmente il cast maschile.
L'incisione DG è invece il documento sonoro d'uno spettacolo cui arrise successo tra i maggiori nella storia del Festival salisburghese del dopoguerra, e il cui scatenatissimo brio indubbiamente afferma la propria vitalità anche nelI'incisione. Traspare tuttavia, e con evidenza anche maggiore, il suo appartenere a un'epoca antica. |
| |
|
| GUIDO CANTELLI
[STRADIVARIUS 1956] |
Il suono resta inevitabilmente un po' inscatolato, ma consente un ascolto pienamente godibile per quanto concerne rapporti strumentali, equilibrio tra voci e strumenti, assenza di distorsioni e rumori di fondo. È un ascolto che, senza mezzi termini definirei esaltante: il Mozart ideale, quello che si è sempre sognato di sentire restandone delusi nove volte e tre quarti su dieci.
I recitativi, in primo luogo. Non è solo questione di ottima pronuncia italiana, anche per le uniche due voci straniere del cast: ma di varietà d'accento, di naturalezza unita a impeccabile musicalità, di perfetto gioco d'assieme che dà l'illusione di un qualcosa nato al momento, come un'improvvisazione capace però di riflettere la casualità della vita stessa. Recitativi che nel loro scintillante, naturalissimo fluire sprigionano l'inconfondibile cifra di opera buffa italiana, ovvero d'una delle matrici più profonde e ricche di Mozart e in particolare del «Così»: quel Settecento italiano di casa alla Piccola Scala di quegli anni felici, senza che per questo nessuno sentisse il bisogno di parlare con sussiego di «rivisitazioni culturali». Una matrice che Cantelli fa circolare per ogni dove, sorta di lievito segreto sconosciuto a qualunque altra edizione. Non è solo la drastica sparizione dei manierismi e dei bamboleggiamenti dai recitativi o, più in generale, dalle linee vocali: ne è immune l'intero timbro orchestrale, che fluisce anziché saltellare, che si fa iridescente anziché ricercare con manierata bravura i colori più preziosi, che nell'affondare in misteriose morbidezze s'ammanta d'ambiguità anziché restare scherzosamente in superficie. E senza che mai questo incredibile dinamismo corra il rischio della nevroticità: ogni nota governata invece da un equilibrio assoluto, unico, che ignora la seriosità per farsi canto, un canto pieno, appassionato, vibrante. [...] Vorrei lare un unico esempio: quella pagina sublime costituita dal duetto Fiordiligi-Ferrando «Fra gli amplessi», una delle più alte di tutto Mozart e quindi di tutta la letteratura musicale. La tradizione, che da Vienna ha sempre fatto scuola, era pressoché costante: Fiordiligi, tra mille mossette e ammicchi al pubblico, si camuffa il più goffamente possibile da uomo; poi arriva Ferrando a corteggiarla in un vistoso «sopra le righe» - facoltativa la periodica comparsa della testa di Guglielmo fra le quinte - onde rassicurare il pubblico che, per carità, sta fingendo e alla fine lei, con la bocca a cuore della bionda scema, cede su un attacco pimpantissimo e trallallero dell'orchestra all'«Abbracciamci o caro bene», l'espressione delle voci e degli strumenti essendo la più giuliva e spensierata possibile.
Sentire cosa succede qui. La transizione l'una nell'altra delle quattro sezioni in cui la scena è articolata, Adagio - Allegro (entrata di Ferrando) - Larghetto («Volgi a me pietosa il ciglio») - Andante, avviene impercettibilmente, senza alcuna soluzione di continuità: ma non perché dappertutto aleggi il sorriso del gioco birichino, bensì per il suo esatto contrario, un progressivo avvitarsi di tensione come traduzione di un'attrazione fisica inequivocabile. Ferrando non finge per nulla, Fiordiligi non smorfioseggia da oca giuliva: sono un uomo e una donna che ad altro non pensano fuorché a loro stessi, a quanto forte sia il reciproco desiderio, a quanto poco valga la pena resistervi. Così, dopo un «Fa di me quel che ti par» che è un lento, esausto - oserei dire doloroso - abbandono alla voluttuosa sinuosità dell'oboe avvolgente la voce come in una penombra ovattata e complice, l'Andante finale per una volta non si muta in inopportunissimo Allegro ma parte sommesso, intimo, come chi assapori fino in fondo un attimo sospeso di felicità, le due voci allacciate in una spirale sempre più liberatoria, sempre più luminosa. Se mai è dato udire la vera voce di Mozart, è in questo punto di questa edizione. |
| |
|
| OTTO KLEMPERER
[EMI 1971

|
Difficilmente Klemperer ha diretto qualcosa senza imprimervi il marchio della propria immensa personalità: avvertibilissimo anche nel «Così» ma, per una volta, assai difficile da apprezzare anche da chi, come me, in Klemperer ha sempre ammirato l'uomo non meno che l'artista, l'uno e l'altro fusi in un modo di far musica che non mi pare fuori luogo definire «etico». Pure, qui davvero la lentezza della dinamica e lo spessore del suono creano una cornice talmente greve da impedire ai personaggi di muoversi liberamente: e se bandita è fin l'idea dello sciocchezzaio petulante di mossette vocali, non lo è per far posto invece a un reale approfondimento delle diverse psicologie. La sulfurea ironia che tanto ha alimentato l'aneddotica su Klemperer sembra lampeggiare, qua e là (Finale primo, ad esempio), ma non mi pare riesca a comporsi in un qualcosa di organico e unitario, quasi l'ascetismo morale di Klemperer rifiutasse d'accettare il sospetto che il cinismo e l'istinto, nel mondo degli affetti, possano rivestire un ruolo più determinante di quello dei cosiddetti alti ideali. |
| |
|
| GEORG SOLTI
[DECCA 1973-1974]

|
L'inclinazione di Solti per una narrazione ricca di tensioni, incalzante, sostenuta da un suono ovunque denso, pastoso e incisivo, sradica dall'opera il più mortale parassita: il bamboleggiamento lezioso sempre in bilico tra coccolezzo ed estasi sublime ma snervata. Lo elimina in modo ancor più radicale dai recitativi, i quali si srotolano guidati dalla regia, nientemeno, dell'allora trentunenne Jeffrey Tate, il cui clavicembalo risponde all'orchestra di Solti con pari vitalità fantasiosa. Come immediato risultato, le passioni qui sono reali, di carne e sensi; l'amore va al di là dell'occhiata birichina ma innocua, e brucia in un duetto Dorabella-Guglielmo gioiosamente carnale oppure, nel suo omologo Ferrando-Fiordiligi colmo di doloroso, turbatissimo smarrimento; l'intrigo portato avanti da Alfonso e Despina non è per niente scherzoso, ma arriva fino ai confini della cattiveria vera e propria, quasi fosse, chissà, l'espressione d'una segreta rivalsa. |
| |
|
| RICCARDO MUTI
[EMI 1982]

|
Primo italiano dopo Cantelli a comparire nella discografia dell'opera, Muti è anche il primo ad affrontarla secondo la visuale di chi, avendo ben in mente cosa realmente sia l'opera buffa italiana, si rende conto che Mozart è sì tutta un'altra cosa ma pur sempre da lì è partito, assumendone gli schemi per svuotarli e rielaborarli di sana pianta - come del resto ha sempre fatto in tutti i campi musicali - ma senza che in tale «ristrutturazione» le pareti esterne ne risultassero alterate. Sparisce dunque, e completamente, la vernice di bamboleggiante leziosità, gli stucchi da rococò viennese che una lunga tradizione ha incrostato su tutta la musica mozartiana, e che particolarmente esiziali risultano nel «Così». Sparisce dall'orchestra non meno che dai cantanti. Orchestra profondamente diversa da quella fattaci conoscere da una tradizione riassumibile nelle direzioni di Böhm. Viva, scintillante, mai slentata in indugi non necessari solo per il gusto di questa o quella belluria timbrica, che frusta i momenti d'azione con un incalzare vorticoso e teatralissimo (un finale primo addirittura mozzafiato), che quando arriva agli abbandoni estatici (cos'è l'accompagnamento dell'«Aura amorosa»!) non si svuota assottigliandosi in fili magari argentei ma nondimeno evanescenti, per restare invece sempre corposa, morbida, carezzevole e vibrante in una stupenda sottolineatura delle linee melodiche: è insomma un'orchestra ben raramente languida e sognante, ma colma invece di pulsazioni ora sensuali ora tese e appassionate, ora persino scopertamente nevrotiche.
Modernissimo, dunque, il Mozart di Muti che pure mai vuole rinunciare - al contrario dei sostenitori degli strumenti originali - alla sovrana bellezza del suono: che nell'edizione solo audio la Filarmonica di Vienna puntualmente sfoggia con compiacimento persino vistoso. Una modernità che vede il «Così» sotto una luce drammatica del tutto diversa da quella del gioco di società frivolo e inoffensivo: un gioco molto serio invece (ma attenzione: mai, mai serioso!), dove quando si ride è col sorriso verdognolo che stira le labbra di chi contempla lati ben poco gradevoli d'un'umanità della quale la cornice quotidiana della vicenda costringe a ricordare di far parte. Benché faccia benissimo intravedere l'evidente, scettico pessimismo del finale, Muti avvolge però la vicenda in una penombra quasi solenne, sintetizzandone così in modo perfetto, i due elementi fondamentali: la sensualità e l'amarezza. La prima, riassunta nella linea melodica di «E nel tuo, nel mio bicchiero»: una delle più belle più intense ma anche - Muti sembra volerci ricordare - una delle più segretamente tristi di tutta la storia della musica. Quell'amarezza riassunta da Guglielmo, che alla fine si arrende a questa insopprimibile sensualità, ma commentandola con un «Bevessero del tossico» cui l'orchestra conferisce un risalto e una sottolineatura inequivocabile.
Così come quanto mai seria è l'impostazione del duetto «Tra gli amplessi», del quale Muti è il primo, dopo Cantelli, a riscoprire il volto autentico: attrazione fisica allo stato puro, che avvicina Ferrando e Fiordiligi sempre più invincibilmente l'uno all'altra, fino a un «Fa' di me quel che ti par» inequivocabile e, dopo, a una conclusione dove si sprigiona per intero quella liberazione, quell'esaltazione che è gioia fisica d'un amore niente affatto inteso come ideale ma come atto che più concreto è difficile immaginare.
E poi, il duettino Fiordiligi-Dorabella del second'atto, uno dei luoghi più saturi di sensualità che la musica abbia mai saputo creare, ma svilito spesso da gridolini canori e riccioluti saltellii strumentali tanto cari a una tradizione restata per lungo tempo immarcescibile: Muti ne renderebbe splendidamente l'atmosfera d'inquieta fantasia erotica, non fosse che nessuna orchestra, per quanto sfarzosa, può annullare la grigiastra povertà timbrica di due voci alquanto povere e gessose. |
|
|
JAMES LEVINE
[DG 1988]

|
Per un direttore l'edettismo può essere sinonimo sia di ricchezza d'esperienza e d'interessi, sia di superficialità: e Levine, in un panorama direttoriale contemporaneo dove prevalgono la prudenza e gli accostamenti centellinati, è direttore il cui eclettismo ricorda quello dei direttori d'una volta. Ma lo ricorda anche nella decisa volontà di anteporre la viva teatralità a qualunque altro valore: atteggiamento che ritengo sia da condividere in pieno, e che trova nella musica di Mozart un terreno fertilissimo di possibilità.
E infatti, dopo un'ouverture scintillante ma allo stesso tempo un poco inerte e priva di vera vita la condotta narrativa si tende in un arco vibrante molto incisivo, lontanissimo sia dai vezzi rococò cari alla tradizione viennese, sia dalla metafisica astrazione sonora cara ai grandi manipolatori del suono. Ma, soprattutto, Levine organizza l'opera attorno a un crescendo. Abbastanza giocosa e spensierata all'inizio, quando la burla diverte gli uomini e lo scoramento delle donne è tutto languore e melanconia, la vicenda viene, per dir così, circoscritta alla musica: languida, iridescente giocata per intero sui colori e sulla luminosità dei diversi ma invariabilmente limpidi piani sonori. Col secondo atto, quando la seduzione delle due donne non viene più portata avanti in coppia ma singolarmente, c'è un percettibilissimo cambio d'atmosfera che si pone come il perno drammatico della narrazione: il gioco pian piano trascolora in serietà, la finzione si arroventa in verità e - circondato dall'evidenziato cinismo di Alfonso e Despina - l'amore cessa d'essere gioco di società per diventare, nel suo impeto scopertamente erotico, di bruciante verità. I tre duetti Fiordiligi-Dorabella, Guglielmo-Dorabella, Ferrando-Fiordiligi, scandiscono questa trasformazione fino a giungere alla scena finale, che sotto l'aspetto levigato e sorridente è tesa in una drammaticità intensa: attraverso un cinico gioco di società i quattro amanti hanno trovato l'amore, quello vero, e ora vi rinunciano consapevolmente in nome delle apparenze che vanno comunque sempre salvate, e mentre si abbracciano, si perdonano giurando d'amarsi, nello stesso momento dicono addio a chi davvero amano; mentre, al loro fianco, la scettica indifferenza di Despina e Alfonso sogghigna e s'afferma come unica verità vera tra tante altisonanti menzogne.
Al centro della propria interpretazione, insomma, modernamente Levine pone l'ambiguità dei sentimenti, e con ciò si iscrive nel ristrettissimo novero di coloro che scendono nelle profondità dell'intricato universo mozartiano anziché restarne alla levigata superficie dei suoni sublimi: e allora certi attacchi non proprio impeccabili certe strappate un po' brusche dell'orchestra
contano ben poco, a fronte del continuo interesse suscitato da scelte insolite di tempi e di sonorità. L'ansia sincera ma non troppo profonda del Quintetto (in cui quattro aristocratici ben educati si danno un addio secondo tutte le regole della buona creanza, e il «Di scrivermi ogni giorno» si fa squisita ma anche svagata miniatura alla Fragonard) è contrapposta all'inquietudine sempre più appassionata della stupenda scena in cui Fiordiligi resiste una prima volta a Ferrando, e con ciò causa in entrambi la scoperta dei loro sentimenti più profondi. Non è un caso se, nelle rappresentazioni di un'opera così poco compresa lino ai giorni nostri, quasi sempre s'ometteva il recitativo accompagnato che ritrae i sublimi abbandoni di Fiordiligi e di Ferrando, nonché la bellissima aria che quest'ultimo canta subito dopo, «Ah lo veggio quell'anima bella / al mio pianto resister non sa», della quale Levine centra mirabilmente l'ambigua confusione sentimentale, col differenziarla in modo netto dalla sublime ma molto più generica estasi languorosa di «Un'aura amorosa»: da una parte quell'amore e dall'altra l'amore come categoria poetica.
Poi la scelta del basso continuo che accompagna i recitativi, affidato alla sonorità calda e vibrante del fortepiano (suonato stupendamente da quel grande maestro sostituto che è Janine Reiss) unito a violoncello e contrabbasso, entrambi Filarmonici di Vienna: ci sono momenti in cui il recitativo secco assume un'intensità e una ricchezza paragonabili a quelle d'un recitativo accompagnato, con effetti drammaticamente singolari, specie nel second'atto. Una direzione, insomma, eccellente nella sua ricchezza di originale personalità. |
|
|
| DANIEL BAREMBOIM
[ERATO 1989]


|
La concertazione di Barenboim si fonda su un suono ampio, maestoso, d'intensa ricchezza di vibrazioni. Pesante, anche, qua e là, rispetto alI'usuale tradizione secondo cui in quest'opera doveva replicarsi la dinamicità della «folle giornata» delle «Nozze» ma non il suo nervosismo espressivo: tale relativa seriosità, però, infonde una carica sovente inedita a molti episodi.
Nel duetto Fiordiligi-Dorabella, ad esempio l'articolazione nettissima insieme all'andamento indugiante e alla corposa densità del suono sprigionano una carica di sensualità addirittura rovente. Il finale primo è tra i più belli mai incisi, dove strepitosa è sia la resa delle alternative di sottovoce e di forte nella prima parte sia la sezione centrale, che è lentissima, ma dai cui letargico indugio si sprigiona un effetto quasi ipnotico, coronato da un vocalizzo finale di Fiordiligi di inedita, estenuata dolcezza: tutto l'ampio episodio si organizza in una drammaticità dura, incalzante, persino stravolta, senza il più remoto accenno all'insopportabile ammicco da «badate-stiamo-scherzando» che tanto spesso fa invece capolino al «Più domestiche e trattabili» dei due uomini, facendo così apparire quanto meno tarde di cervello le due ragazze, costrette a cadere in una burla resa tanto evidente. Si può forse rimproverare a Barenboim una certa uniformità originata dal partito preso del denso spessore sonoro: pure, al suo interno formicola una notevole ricchezza di contrasti dinamici a rendere pulsante il racconto, e quasi a costringere i cantanti a ricercare una continua varietà di fraseggio, impedendo ogni comodo adagiarsi in eventuali edonismi vocali. |
| NIKOLAUS HARNONCOURT
[DECCA 1988]
[TELDEC 1991] |
|
| JOHN ELIOT GARDINER
[ARCHIV 1992
AUDIO E VIDEO]

|
Il «Così fan tutte» che Gardiner, alla testa dei propri complessi barocchi, ha messo in scena a Lisbona, Ferrara e Parigi nel quadro d'un accordo di coproduzione tra i teatri di queste città, fu uno degli spettacoli di maggior successo degli ultimi anni: è stato oggetto d'una registrazione solo audio a Ferrara, e d'una videoregistrazione allo Chatelet di Parigi. Due realizzazioni quasi sovrapponibili: l'unica variante nel cast riguarda Alfonso, in CD Carlos Feller più bravo - se non altro per la ben diversa padronanza linguistica - di Claudio Nicolai, che nonostante il nome è nativo di Kiel; e unica variante testuale è l'assenza, nei laserdisc, dell'aria di Ferrando «Ah lo veggio» e dell'aria alternativa di Guglielmo «Rivolgete a lui lo sauardo», che il CD porta come appendice. Ma la concezione che dell'opera presenta Gardiner si rivela compiutamente solo nell'unitarietà teatrale offerta dalla videoregistrazione. Succede sempre, si capisce: ma assume particolare rilevanza quando, come in questo caso, la regia sia dello stesso direttore d'orchestra, che s'è avvalso dell'esperienza tecnica d'un collaboratore per realizzare appieno quanto l'interpretazione musicale gli suggeriva in merito allo svolgimento scenico della vicenda. La qual cosa, di per sé, non è garanzia assoluta di automatica traduzione in grande spettacolo, come ben sa chiunque abbia assistito, ad esempio, a una messinscena di Karajan: ma questa è la classica eccezione, al punto da rappresentare una pietra miliare scenica non meno che musicale nella storia interpretativa dell'opera.
Nemmeno a dirlo, per Gardiner «Così fan tutte» è null'affatto una deliziosa sciocchezzuola sentimentale ma, come scrive lui stesso, «uno psicodramma emotivo, pregnante quanto quelli di Marivaux, ma che guadagna in eloquenza dal fatto d'essere cantato e non recitato, e di venir filtrato dall'affascinante prisma dell'orchestra mozartiana». Gardiner, inoltre, richiama opportunamente una notazione di Saul Bellow a proposito del sottofondo di melanconia sempre sotteso alla musica mozartiana, che dell'illuminismo tramontante esprime alla perfezione la lucida concretezza della speculazione intellettuale, ma nel contempo ci fa sentire come «ciò che ci si chiede di comprendere è troppo grande per noi». L'opera diventa così - come con Harnoncourt e Ponnelle, ma con maggiore indulgenza nei confronti della gioventù - una sorta di viaggio alla comprensione di se stessi: condotto sul filo di tempi la cui elastica pulsione tra stringatezza e rilassamento tende sempre più a privilegiare quest'ultimo man mano che la sentimentalità stereotipata dell'inizio viene soppiantata dalla ben più autentica sensualità che erompe dal profondo d'un inconscio fino allora racchiuso nei rigidi schemi dell'ordine costituito. Al modo stesso con cui l'elegante pavimentazione della terrazza aperta sulla campagna - su cui gran parte della vicenda si svolge - viene progressivamente sconvolta e sgretolata dal proliferare di agavi, aloi e fichidindia, che avvolgono i quattro giovani in un'atmosfera lussureggiante ma anche sottilmente pericolosa, nella quale lo smarrimento erotico diviene dolcissima trafittura.
Impossibile naturalmente, dar conto delle innumerevoli idee che animano e articolano una narrazione di scioltezza, naturalezza e comunicativa eccezionali. Ma va sottolineato il rischio corso nello scritturare un quartetto di artisti tutti compresi tra i venti e trent'anni, chiamati ad affrontare una musica tanto difficile: un rischio evidentemente calcolato, giacché talune mende vocali (nessuna grave, peraltro, e comunque riscontrabile senz'altro più al solo ascolto che non alla fusione di questo con le immagini) vengono completamente riassorbite dalla spontanea verità esistenziale assunta dalla vicenda se vissuta da due coppie poco più che adolescenti e di belI'aspetto, capaci per giunta d'un gioco scenico consumatissimo.
Coppie che ci vengono presentate subito nell'anonimo conformismo di stereotipi riflesso nell'identità dell'abbigliamento dei due uomini e delle due ragazze: machismo un po' borioso per i primi e languore castigato per le seconde, la cui affinità è particolarmente accentuata lungo l'intero primo atto, fino al punto (e qui Gardiner si spinge oltre il bordo del lecito) che in «Smanie implacabili» una battuta della ripresa - «Esempio misero d'amor funesto» - la dice Fiordiligi al posto di Dorabella, cosl come più tardi avverrà uno scambio inverso in «Come scoglio». Una gemellanza - meglio, un'interscambiabilità anche affettiva - che via via si muta nella consapevolezza di identità diverse, riflesse alla superficie dalla mutata foggia degli abiti (nei quali la sinuosa morbidezza e il caldo colore pastello pian piano la vincono sulla rigidità delle forme e sulla slavata compostezza delle tinte iniziali), dalla scomparsa dei quattro specchi che al primo atto, sullo sfondo, riflettevano le identità deformandole e ricomponendole. Il tutto, man mano che la componente selvaggia e irrefrenabile d'una natura illusoriamente dolce e composta nelle pitture dello sfondo e dei siparietti (ispirati al gallese Thomas Jones e alle gonaches di Tito Lusieri) s'afferma erompendo sulla levigata civiltà d'una pavimentazione geometrica.
L'integrazione dei gesti con i tempi e le sonorità musicali è assoluta, l'una potenziando l'altra - e viceversa - come solo di rado è dato riscontrare a teatro. Nel finale primo, il finto medico ha «mesmerizzato» i falsi moribondi, oltre che col magnete, con due languide penne di pavone: le stesse con cui i redivivi percorreranno analogamente, ma con ben maggiore intenzione, i corpi delle ragazze, in un'ondata di morbida sensualità sotto l'increspatura delle voluttuose cadenze delle linee vocali femminili. Il languore del duetto Dorabella-Guglielmo fluisce con straordinaria morbidezza, innervata però da pulsioni sempre più scoperte e incisive, concluse non dal solito e incongruo scappar via a saltellini, ma - con concretezza ben più logica - dal loro scivolare a terra in un abbraccio rovente. Straordinarie le inquadrature della successiva scena Ferrando-Fiordiligi in cui, nell'infuocata luce da caldo tramonto mediterraneo, una disordinata eruzione vegetale amplifica l'inflettersi doloroso dell'accompagnamento a linee vocali che ancor più sembrano struggenti nella credibilissima attrazione fisica con cui s'allacciano due adolescenti. Una splendida sonorità (quei corni!) immerge «Per pietà ben mio perdona» in una sorta di vuoto splrltuale, dl sospenslone del sentimenti nel momento stesso in cui Fiordiligi evoca il proprio amore: e l'oggetto di tale amore, sullo sfondo oscuro d'una natura in rigoglio, lo vediamo congedarsi da un'altra con la spossata tenerezza che segue l'amplesso.
Davvero remotissime, il frullo di crinoline e le mossettine cui era una volta circoscritta l'opera; lontana anche la traslucida Metafisica del Bello che nella perfezione di forme classiche imbalsamava la viva concretezza dei sensi aui posta invece in primo piano, sulla linea del generale rinnovamento mozartiano portato avanti con mezzi e risultati diversi da Hogwood, Harnoncourt, Abbado, Gardiner: il quale ultimo, nei confronti della sensualità - ovvero delI'elemento oiù ambiguo e ricco di sfaccettature del teatro di Mozart - nel renderne manifesta e fondamentale la forza e la «naturalezza» intrinseca alla natura dell'uomo, la immerge anche in un'atmosfera di malinconica tenerezza, di doloroso struggimento, tanto delicato e forte insieme da costituire, per mio conto, quanto di più profondo sia stato espresso in quest'opera tanto affascinante e - dell'intero teatro mozartiano - sicuramente la più immediatamente riconducibile alla viva realtà d'ogni tempo e luogo. |
| SIGISWALD KUIJKEN

|
Una magnifica direzione, simile a quella di Gardiner non solo nell'impiego degli strumenti originali, ma anche nella scelta di molte sonorità, tuttavia ancora più nitide, ricche fino al limite dell'eccesso di forti contrasti nei quali l'acidità timbrica dello strumentale è utilizzata in modo strepitoso per immergere la vicenda nella quotidianità della vita reale con le sue durezze, le sue pulsioni erotiche, le sue ambiguità e, in modo percettibile, le sue miserie: sulla nuda terra, insomma dove abitiamo anche noi dell'ultimo scorcio del ventesimo secolo, ben al di sotto delle celesti contemplazioni metafisiche e delle loro dolcezze estenuate, innocuamente contemplative. Sostituite dunque da un tumultuoso impulso vitalistico, cui una scelta di tempi dalla giustezza a mio avviso eccezionale - un finale primo, in particolare, di progressione straordinaria - imprime un carattere personalissimo e affascinante.
|
| CHARLES MACKERRAS |
Orchestra d'organico ridotto, che impiega strumenti moderni ma, per così dire, «pensa» all'antica nei suoi tempi per lo più rapidi, nella contrastata ma nitidissima articolazione interna specie degli episodi d'assieme, nel valore preminente accordato alla timbrica dei fiati, nel privilegiare di gran lunga l'aspetto ritmico e dinamico sulla ricerca dei coloriti preziosi, dell'indugio paradisiaco, della belluria che non risponda a precisi fini teatrali. Un approccio moderno, quindi che paga notevoli dividendi sul fronte della vivacità e della logica narrativa: cui tende anche il cospicuo impiego delle appoggiature vocali. Le quali, tuttavia, sortiscono eltetto diverso se a farle sono Corbelli e la Focile, ovvero i due italiani, oppure gli altri: giacché l'appoggiatura (ovvero emettere una nota non direttamente ma attaccandola mezzo tono sopra e subito scendendo, con effetto quindi enfatizzante) un italiano non la «fa» - specie nei recitativi - ma, se possiede un minimo di talento espressivo, gli viene spontanea con l'accento da conferire a questa o quella parola, insieme alle sottili variazioni dinamiche all'interno d'un dato tempo, legate alla maggiore o minore durata delle diverse sillabe componenti una parola. E dunque il canto della Focile e ancor più quello di Corbelli fluisce spontaneo, naturalmente espressivo nell'assenza d'ogni inopportuna sottolineatura: quello degli altri manifesta spesso, invece, una percentuale variabile ma comunque significativa di ricercato manierismo. |
|
 |
|
|